Diversi adulti, giovani e meno giovani, si trovano confrontati spesso con delle difficoltà che ormai sospettano abbiano a che fare con la dislessia o con qualche altro Disturbo Specifico dell’Apprendimento.
Pensi di avere anche tu una dislessia in età adulta? Andiamo un po’ più nel dettaglio.
Perché si crea questa situazione? Spesso succede perché i DSA prima del 2010 erano difficilmente diagnosticati. Infatti a riprova, sono nate diverse polemiche intorno al aumento di certificazioni di DSA. Malgrado quello che sostengono alcuni, l’incremento non è dovuto alla facilità della diagnosi, ma alla rara identificazione dei DSA nel passato. A conferma di ciò le percentuali attuali sono in linea con gli altri paesi.
Cosa comporta l’essere un adulto dislessico non diagnosticato?
La prima cosa che la mia esperienza di mamma mi indica, è l’effetto deleterio che ha un percorso scolastico sofferto. Infatti avendo la diagnosi, per noi è stato difficile e pesante. Non posso immaginare quanto lo sia stato ancora di più per qualcuno che non ne capisse la motivazione. Oltre a ciò, dato che non si riesce a fare le stesse cose degli altri, ci si sente continuamente mortificati. In aggiunta, siccome le facoltà intellettive nelle persone con DSA sono nella norma o superiori, si è sistematicamente accusati di non impegnarsi abbastanza. Tutto questo ha inevitabilmente un impatto psicologico molto pesante.
Perché capire se sono dislessico
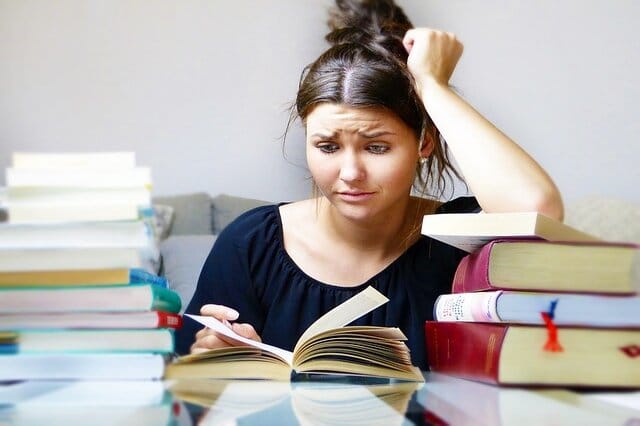
Dopo quanto detto si intuisce già buoni motivi per volere delle risposte. La dislessia nel adulto si può esprimere in modi molto diversi da persona a persona e a seconda dell’età. La cosa che rimane comune praticamente a tutti quelli senza diagnosi è il disagio dovuto a questo dubbio che li attanaglia. Questa perenne incongruenza tra quello che sente di essere capace di fare e i risultati che ottiene lascia l’amaro in bocca. Ecco perché può essere significativo togliersi il dubbio.
Oltre all’aspetto psicologico ne esiste anche uno pratico. Qualcuno si chiede che lavoro può fare un dislessico. È vero che i DSA negli adulti comportano delle difficoltà, ma ciò non toglie che un dislessico può seguire le proprie aspirazioni professionali, anche andare all’università. Un dislessico può diventare medico, per esempio, ma deve essere consapevole del suo personale modo di essere e usare le strategie a lui più funzionali. Quindi il primo passo è certamente capire se si è o no dislessici adulti.
Si può diventare diventare dislessici da adulti?
Totò diceva “Signori ci si nasce”. Questo vale anche per i DSA. Sono una caratteristica neurobiologica che si ha dalla nascita. Si esprime con le prime acquisizioni della letto-scrittura. Di fronte allo stimolo della lettura, i dislessici non riescono ad imparare e/o automatizzare questo processo.
I DSA si evolvono nel corso della vita. Per esempio per la dislessia nei primi anni di scuola c’è maggiore difficoltà di accesso alla lettura, ma in seguito il problema si sposta sulla capacità di leggere in modo automatico con una richiesta d’impegno maggiore, infine, in età adulta possono persistere alcune caratteristiche. Magari la velocità può essere aumentata, ma rimane distante dalla media attesa e comunque persistono difficoltà nella correttezza e nel controllo della lettura di alcune parole.
La dislessia negli adulti può dipendere dallo stress?
Lo stress non favorisce mai l’apprendimento. Tuttavia la dislessia non dipende dallo stress. È ovvio che una persona che ha avuto un percorso scolastico legato ai DSA sarà più sensibile allo stress generato dall’apprendimento e può subire ansia da apprendimento. Cionondimeno una persona non dislessica sotto pressione può avere delle difficoltà ad apprendere, ma non dipende dalla dislessia in senso specifico.
Come si capisce se si è dislessici?
Bisogna tornare indietro con la mente. Solitamente si capisce se si è dislessici nel momento in cui, di fronte allo stimolo della scolarizzazione, non si è riuscito a sviluppare determinate tappe di competenza e precise capacità nei tempi e nei modi previsti nella norma. Il persistere di queste caratteristiche fanno sì che dalla seconda alla terza elementare si può chiarire se si è dislessici. Nei bambini ci sono anche degli indicatori pre scolastici che puoi scoprire qui.
Ad ogni modo servono delle prove standardizzate. Batterie di test che tengono conto del disturbo esaminato e dell’età della persona.
Quali sono i sintomi della dislessia negli adulti?
Al di là del risultato di questi test, tarati dai medici, che hanno una validità clinica. I sintomi in età adulta sono:
- la mancata automatizzazione di alcuni processi;
- la tendenza a fare determinati errori;
- la difficoltà a mantenere la concentrazione sul testo, rendendo inefficace la comprensione;
- la tendenza a fare piccoli errori ortografici persistenti;
- la difficoltà a reperire velocemente il lessico necessario per esporre e argomentare ciò di cui si vuole parlare, indipendentemente dalla conoscenza dei significati.
Rispetto a quest’ultimo punto è buono sottolineare che la problematica non è dovuta ad una difficoltà intellettiva, perché le persone dislessiche conoscono il significato di un buon numero di termini, ma è un problema linguistico. Recuperare velocemente un termine coinvolge i processi interessati dalla dislessia.
Nel caso di un DSA adulto, a chi bisogna rivolgersi?
È importante rivolgersi ad uno specialista competente. Un medico, psicologo o neuropsichiatra competente, utilizzerà la batteria di test in maniera corretta e completa.
Questo è il motivo per cui, per esempio, la logopedista nella fase clinica è solo coinvolta, ma non è quella che determina la validità di tutto l’iter clinico. Lei potrà svolgere solo alcune prove. Il protocollo necessario ad una diagnosi clinica completa include la valutazione cognitiva, la valutazione delle abilità, delle singole abilità di lettura, scrittura e calcolo. Per di più in un protocollo completo, utile a tracciare un profilo di sviluppo, è bene inserire anche test che diano informazioni sui processi esecutivi, come la memoria, l’attenzione, la memoria di lavoro e di linguaggio.
Per di più è importante sottolineare che per gli adulti, ai fini istituzionali, la certificazione deve provenire dall’ASL o da specialisti accreditati.
Non accontentarsi della diagnosi
Fare la diagnosi è fondamentale. Però dobbiamo fare una precisazione nei termini. È più vantaggioso fare una valutazione, non vuol essere un gioco di parole tra diagnosi e valutazione.
Una valutazione mette in luce il proprio profilo di funzionamento. Se funzioniamo in un modo inefficace, la valutazione determinerà se il motivo è legato ai DSA o ad altre ragioni. Se un profilo di funzionamento risulta positivo ai test di letto-scrittura e calcolo, solo allora verrà posta la diagnosi. La valutazione mette in luce non solo i punti deboli, ma anche i punti di forza, indispensabili da conoscere e poi sfruttare.
Cosa può fare un adulto dislessico
Siccome le fasi di acquisizione sono ormai stabilizzate, anche se non perfette, lo sforzo richiesto per esercizi o terapie non ne varrebbe la pena. Per questo motivo l’attenzione dev’essere rivolta diversamente. A seconda del proprio profilo di funzionamento e del bisogno, si concentrerà su:
- l’acquisizione di strumenti adeguati a migliorare gli aspetti funzionali;
- strumenti metodologici, quindi imparando ad approcciarsi al compito di studio, di esposizione, di utilizzo dei materiali didattici in maniera più organizzata con delle strategie;
- eventualmente se può essere utile, un piccolo supporto psicologico o supporto psicoterapico, preferibilmente cognitivo-comportamentale per ricostruire un po’ di immagine generale che la persona si è fatta e quindi ridefinire un po’ anche gli aspetti psicologici e motivazionali.
Dislessia adulti e lavoro
Quando il dislessico è confrontato al mondo del lavoro, la parola d’ordine è: consapevolezza.
Può essere utile ridefinire quelle che sono le cadute che avverte nel contesto lavorativo. Per da un lato compensarle fin dov’è possibile e ottimizzare il proprio lavoro senza incorrere in errori dovuti appunto alla dislessia. Dall’altro lato per rapportarsi correttamente con i propri datori di lavoro con, giustamente, consapevolezza.
È da notare che si sta evolvendo una normativa legata al mondo del lavoro, l’Associazione Italiana Dislessia è molto impegnata in questo senso. La legge 170 si ferma alla scolarizzazione secondaria e all’università. Nell’ambito lavorativo, la direzione è più come welfare aziendale, per cui ci sono aziende che si interessano di rendere i test d’ingresso delle loro aziende accessibile o si preoccupano di mettere i loro dipendenti dislessici in condizione di sfruttare altre potenzialità che rimarrebbero inespresse. L’AID definisce queste aziende Dyslexia Friendly Company.
Un dislessico può andare all’università
L’università è un percorso fattibile, ma è bene che lo studente sappia che esistono degli sportelli universitari di supporto, anche se questi possono fare solo alcune cose, e che è importante sfruttarli al massimo. Ovviamente per questo è necessaria una certificazione DSA vidimata dall’ASL.
D’altra parte è indispensabile migliorare il proprio metodo di studio, inserendo metodi e strumenti adeguati, migliorare la relazione con i propri interlocutori che siano professori, gruppi di studio, ecc..
Togliti ogni dubbio
William Shakespeare disse che “i nostri dubbi ci tradiscono, e impedendoci di affrontare la battaglia ci precludono sovente i dolci frutti della vittoria”. Perché “precluderti i dolci frutti della vittoria“? Non rimanere nel dubbio e dai una svolta al tuo percorso accademico o professionale. Impara a conoscere e sfruttare appieno le tue potenzialità.
